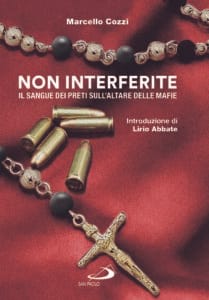
“Un pentito mi disse: la più grande arma contro la mafia? Parlatene di più”: la Chiesa che si batte contro la criminalità nel libro di don Marcello Cozzi
Il Fatto Quotidiano - Monday, December 1, 2025“Se da un lato non mancano figure ecclesiastiche che hanno ceduto alla paura o al compromesso, dall’altro ci sono sacerdoti che, vivendo il Vangelo fino in fondo, hanno interferito con gli affari e le logiche di potere delle mafie, pagando talvolta con la vita la loro fedeltà alla giustizia”. A parlare è don Marcello Cozzi, sacerdote lucano che, impegnato da sempre nella difesa dei più fragili e nella denuncia 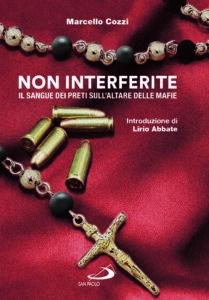 delle ingiustizie, ha fatto della sua missione un cammino dentro le zone d’ombra della società. Nel suo libro Non interferite. Il sangue dei preti sull’altare delle mafie (Edizioni San Paolo) racchiude le storie di sacerdoti che non hanno avuto paura della criminalità organizzata, invitando tutti a non restare indifferenti dinanzi al male che cerca di infiltrarsi nei luoghi della fede e della vita civile.
delle ingiustizie, ha fatto della sua missione un cammino dentro le zone d’ombra della società. Nel suo libro Non interferite. Il sangue dei preti sull’altare delle mafie (Edizioni San Paolo) racchiude le storie di sacerdoti che non hanno avuto paura della criminalità organizzata, invitando tutti a non restare indifferenti dinanzi al male che cerca di infiltrarsi nei luoghi della fede e della vita civile.
Don Cozzi, cosa le ha fatto sentire l’urgenza di scrivere questo libro?
Innanzitutto, la necessità di ricordare che don Pino Puglisi e don Peppe Diana non sono stati gli unici preti ad essere stati ammazzati dalle mafie, ma anche tanti altri, dei quali non si conoscono i nomi e le storie. Quindi ci ho tenuto a restituire dignità a tutti quei preti invisibili che lottano contro le mafie e, in questa guerra, ci hanno rimesso la vita, non ricordati da nessuno. In tal modo attesto che c’è sempre stata anche una Chiesa martire, simbolo di quella foresta che cresce in silenzio a dispetto del rumore di un albero che cade.
Il rapporto tra Chiesa e mafia ha origini fortemente radicate nel passato?
È una storia antica di connivenze, ma anche di contrasti. Affonda le sue radici nell’antichità stessa del fenomeno mafioso, non solo per la necessità che da sempre le organizzazioni criminali hanno avuto di accreditarsi anche culturalmente e religiosamente presso la Chiesa, ma anche per il controllo che hanno voluto esercitare su di essa, come su ogni altra dimensione della società.
Questi sacerdoti che, sin dall’Ottocento, hanno combattuto contro ogni forma di mafia – e a causa del loro impegno e del loro rifiuto di ogni compromesso sono stati ammazzati – hanno rappresentato una sorta di guida per il suo cammino sacerdotale?
Indubbiamente le storie di don Puglisi e don Diana, nel mio percorso ecclesiastico, hanno rappresentato un importante punto di riferimento. Però, quando ho iniziato ad approfondire le storie di questi preti che, già secoli prima, lottavano contro la prepotenza criminale e mafiosa per difendere poveri e oppressi di vario tipo, è come se fossi stato travolto da una montagna di testimonianze sacerdotali che, indubbiamente, mi hanno arricchito non solo per il loro impegno, ma anche per la loro profonda spiritualità.
Ha deciso di ripercorrere le loro battaglie per celebrarli giustamente, ma anche per ricordare alle nuove generazioni qual è la strada della giustizia da intraprendere, per mostrare vite da emulare?
Indubbiamente sì, urge diffondere la cultura della legalità e della solidarietà tra i giovani. Ma non nascondo che mi piacerebbe far conoscere queste storie anche all’interno del mondo ecclesiale, per dimostrare che non esistono preti antimafia. Sono preti e basta, come diceva don Puglisi, che hanno semplicemente vissuto e annunciato il Vangelo della liberazione dall’oppressione mafiosa, e per questa interferenza sono stati ammazzati.
Nel suo piccolo sente di aver raccolto il loro testimone?
Non spetta a me dirlo, però finora ho vissuto il Vangelo come impegno al fianco delle persone svantaggiate, quindi sento di far parte della stessa grande storia che mira ad annunciare la liberazione. Qui in Basilicata la presenza mafiosa non si percepisce nel modo più convenzionale, quindi è più complesso l’impegno per l’affermazione della giustizia.
Qual è stato l’avvenimento che ha avviato questo suo impegno?
In particolar modo, l’incontro, nel 1991, con una ragazza che si faceva di eroina. Un giorno, raccontandosi, mi mise per iscritto l’organigramma di chi le procurava la droga, le piazze di spaccio, i nomi di chi stava all’apice. In quel momento ho capito che non potevo approcciarmi al problema della tossicodipendenza solo dal punto di vista del disagio sociale, dovevo mettere mano a quella macchina nascosta che speculava sulla fragilità di tanti giovani. La droga era ed è un business di mafia, non potevo voltarmi dall’altra parte.
In quello stesso anno, quando era prete da meno di un anno, incontrò anche una vittima di usura.
Sono certo che il Padreterno, attraverso certi incontri, ci indichi la rotta. Ai tempi non sapevo niente di usura, ma percepii subito che quella persona non era libera, viveva oppressa dai debiti e strangolata da chi approfittava della sua condizione di fragilità. Sentii che quella persona mi apparteneva e con lei tutti quelli che vivevano quella schiavitù.
Per tale motivo, anni dopo, ha fondato la Fondazione antiusura “Interesse uomo”?
In seguito a quell’incontro e ad altre storie simili, in collaborazione con la Provincia di Potenza, nel 2002, costituii questa fondazione che, attraverso sportelli attivi in tutta Italia, aiuta economicamente coloro che non hanno più accesso al credito ordinario – soprattutto imprenditori e commercianti – evitando che finiscano nella morsa degli usurai.
Volge lo sguardo anche all’educazione alla legalità, infatti ha fondato e guida l’Istituto di ricerca e formazione interdisciplinare sulle mafie. Qual è il suo obiettivo?
L’Irfi è nato due anni fa, con la benedizione del cardinale Mimmo Battaglia, con l’intento di aiutare le nostre Chiese, particolarmente nel Sud Italia, ad affrontare i fenomeni mafiosi. Non si tratta solo di avviare ricerche sul rapporto tra Vangelo e religiosità mafiosa, ma creiamo anche strategie pastorali affinché, in certi contesti particolarmente aggrediti dalla presenza mafiosa, le comunità parrocchiali e gli stessi preti possano essere sostenuti.
È impegnato anche nell’accompagnamento spirituale dei collaboratori di giustizia. Com’è iniziato questo percorso?
Nel 2000, ricevetti una telefonata dalla compagna di un collaboratore di giustizia che voleva parlarmi, da lì è partito questo mio delicato impegno. In questi anni avrò incontrato più di un centinaio di collaboratori di giustizia, tutte storie diverse, segnate da violenza e morte. Per me è importante che questi accompagnamenti siano un incontro tra umanità, non per mettere la bandierina della redenzione a un peccatore incallito che mi chiama per essere confessato. Ho imparato ad ascoltare e a non fermarmi alla superficie, con la consapevolezza di avere davanti una persona che, nel ridurre a brandelli l’umanità di altri, ha distrutto anche la propria. Sono sempre più convinto che, per rendere efficace la lotta alla mafia, bisogna scendere in quell’inferno, parlare con il suo ventre molle, incontrare queste persone normali che hanno commesso azioni mostruose, senza mai smettere di chiedersi il motivo. Proprio come feci con uno dei più noti pentiti, Giovanni Brusca.
Secondo la sua esperienza, cosa servirebbe per annientare l’”interferenza” tra Chiesa e mafia e far prevalere la giustizia?
Una volta a un collaboratore di giustizia calabrese chiesi cosa, secondo lui, avrebbe potuto fare la Chiesa per contrastare le mafie. Mi rispose che dobbiamo parlarne di più, dobbiamo denunciare maggiormente, in quanto loro spesso hanno approfittato dei nostri silenzi e a volte li hanno percepiti come consensi. Dobbiamo uscire da certe ambiguità, andando nelle periferie. Credo che, oggi più di prima, la Chiesa sia chiamata a stare qui, dove, come diceva Papa Francesco, c’è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni.
L'articolo “Un pentito mi disse: la più grande arma contro la mafia? Parlatene di più”: la Chiesa che si batte contro la criminalità nel libro di don Marcello Cozzi proviene da Il Fatto Quotidiano.
