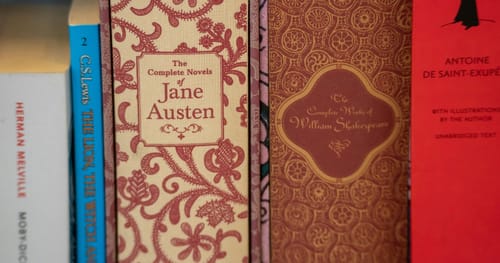
Jane Austen, eroina ribelle e antiromantica. Per me un modo di essere necessario
Il Fatto Quotidiano - Tuesday, December 16, 2025La sua aristocratica solitudine è il paradigma del genio dorato che ogni scrittore vorrebbe abitare. Jane Austen per chi scrive è uno scandaglio da cui discendere. Un poggio a cui guardare. Una traduzione romantica del mestiere di scrivere. Anche se lei non cercava il sentimento, il suo, dicono i bibliografi e certa critica, era il romanzo della conoscenza. Per altri, l’elemento vacuo, estetico, prevaleva sul contenuto. Ma Jane doveva salvarsi, utilizzando – riferiscono studi accademici – la misura formale. Dunque a metà. Salvarsi da una sensibilità estrema. Malgrado fossero romanzi connotati da un dichiarato antiromanticismo, in lei riscontriamo molto romanticamente piuttosto i tratti di una eroina ribelle, emancipata, proprio come vorremmo immaginarci un’artista del tempo.
Una vita quieta, di una pacificità agiata, annoiata sì, con un paio di rinunce e un amore straziato, interrotto da una morte precoce. Basta a rendere la malinconia epica e struggente che la circonda, complice la nostra intenzionalità. Crinoline e miniature di un mondo alto-borghese passato al monocolo: è riuscita a nutrire un sogno corale, la leggerezza della lettura avrebbe permesso al lettore una fuga salvifica, può darsi l’identica fuga che moveva la creatività fervida di una giovane donna, la scrittrice che rifiutò il matrimonio e le banali pratiche quotidiane in luogo di una vita breve, incompiuta, confacente a restituirci una figura perciò leggendaria.
Eppure ricordiamo meglio lei, che altre donne femme de lettres, visto che il secolo aveva fornito un tale primato: Eliza Haywood, Fanny Burney. E Jane. Jane pare si fosse ispirata a una frase di un personaggio della Burney per Orgoglio e pregiudizio. Il personaggio era Cecilia: “Tutta questa sfortunata faccenda è stato il risultato di orgoglio e pregiudizio”.
Sfortunata faccenda, con quella noia colta, detta superficialità mondana, che in realtà sprofondava in elevatissime certezze: l’amore. Sempre conficcato in una qualche iconica fragilità. Una impossibilità. Una lettera non recapitata. Un ballo mancato.
La Austen non amava la mondanità di provincia. Si racconta del deliquio che la colse, quando ancora era una giovinetta, appreso che avrebbe dovuto trasferirsi a Bath, una innocua, tediosissima città termale. Non amava quel luogo, non amava la gretta civettuola socialità. Da lì ne trasse il romanzo Northanger Abbey. Una accusa celata all’universo grasso e fastoso di una mediocre cittadina di provincia.
Per me che ho coltivato la scrittura nella identica solitudine, rinuncia e avversione noiosa, la Austen era un modo di essere necessario per raccontare la vita. Romanticamente dicevo, di quel romanticismo, ironico e amaro insieme, o anche del suo esatto contrario. Un antiromanticismo che giocando con la soglia più a buon mercato del sentimento ne enuncia la tragicità segreta.
Figure sottili, delicate, eleganti. La Austen ne è il simbolo. Ogni scrittrice, chissà, avrà pensato un po’ anche a lei, lungo la strada di solito erta degli inizi, alla sua giovinezza, tradita dal destino che non si è fermato in tempo a renderla felice, amata di quell’amore necessario a vibrare dentro un’esistenza, finanche vita: che non sia soltanto uno scorrere ordinato e feroce di silenzi o ripetute quotidianità.
Così morirà abbastanza presto, in anticipo sullo sfiorire irreparabile. Una grazia in fondo.
L'articolo Jane Austen, eroina ribelle e antiromantica. Per me un modo di essere necessario proviene da Il Fatto Quotidiano.
